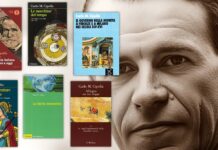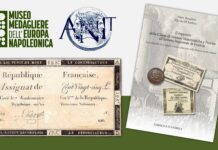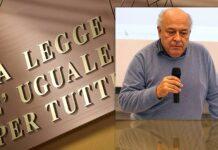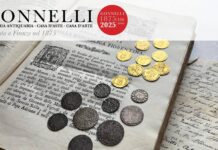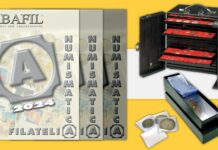Venticinque anni fa, il 5 settembre del 2000, moriva nella sua Pavia il professor Carlo M. Cipolla (1922-2000). Da giovane avrebbe desiderato insegnare storia e filosofia in un liceo ma, una volta iscrittosi alla facoltà di Scienze politiche della sua città incontrò il professor Franco Borlandi, esperto quella storia economica medievale che sarebbe diventata uno dei suoi campi di appassionata ricerca.
Studia alla Sorbona di Parigi, alla prestigiosa London School of Economics e nel 1949, ad appena 27 anni, ottiene a Catania la prima cattedra in Storia dell’economia. Insegnerà poi a Venezia, Torino, Pavia, alla Normale di Pisa e all’estero, ad esempio all’Università di Berkeley in California.
L’Università di Pavia gli conferisce nel 1992 una laurea honoris causa, riceve nel 1995 il Premio Balzan per la Storia economica e l’ateneo pavere gli intitola in seguito il Dipartimento di Scienze storiche e geografiche per poi acquisire, nel 2001, gran parte della sua enorme biblioteca che raccoglie opere di storia economica e, in particolare, di storia della moneta (Fondo Carlo M. Cipolla presso la Biblioteca di Studi umanistici “Francesco Petrarca”).
 A Carlo M. Cipolla si deve l’evoluzione del metodo di approccio alla storia economica nel nostro paese. Prima di lui la disciplina è descrittiva e non analitica, in fondo “fenomenologica” e quasi sterile dal punto di vista del contributo alla storiografia generale intesa in senso moderno.
A Carlo M. Cipolla si deve l’evoluzione del metodo di approccio alla storia economica nel nostro paese. Prima di lui la disciplina è descrittiva e non analitica, in fondo “fenomenologica” e quasi sterile dal punto di vista del contributo alla storiografia generale intesa in senso moderno.
Amante e finissimo conoscitore della moneta e della sua storia, Cipolla comprende che dietro all’introduzione delle nuove specie – quelle in oro argento, ma anche gli “spiccioli” di ogni epoca – nonché dietro le fluttuazioni delle valute e quindi dietro i cambiamenti economici ci sono gli uomini, guidati dalle loro menti, dalle loro ambizioni e contingenze, dai macro fenomeni come le carestie, le guerre, le epidemie.
La moneta e l’economia, se prese in esame alla luce di questo elaborato sistema di cause ed effetti – mai lineare, quasi sempre reticolare e di notevole complessità – si rivelano come espressioni umane tutt’altro che mute. Così Carlo M. Cipolla prende come parametri di studio le pestilenze, l’introduzione delle tecnologie, le scoperte scientifiche e nel leggere – o rileggere – i suoi innumerevoli saggi il numismatico trova giustificazione a pagine di storia della moneta di cui non conosce i retroscena o ne conosce solo frammentati elementi.
 Quando scrive di stabilità del fiorino di Firenze o del ducato di Venezia, di rapporti di cambio oppure di svalutazione delle lire di denari in alcune città d’Italia, o ancora di prezzi di merci comparate nello spazio e nel tempo, Cipolla restituisce alle monete e alla moneta vita e motivazione, ben al di là del loro aspetto, del loro intrinseco e del loro valore collezionistico.
Quando scrive di stabilità del fiorino di Firenze o del ducato di Venezia, di rapporti di cambio oppure di svalutazione delle lire di denari in alcune città d’Italia, o ancora di prezzi di merci comparate nello spazio e nel tempo, Cipolla restituisce alle monete e alla moneta vita e motivazione, ben al di là del loro aspetto, del loro intrinseco e del loro valore collezionistico.
Le monete, del resto, sono solo una categoria – per quanto primaria – in quella varietà delle fonti che permette, sono parole sue, di “parlare con i numeri” dell’economia. Cipolla lo fa sempre con uno stile narrativo e quasi colloquiale, uno stile divulgativo ma dall’elevato spessore concettuale in cui non di raro affiora un umorismo sottile, al quale lo studioso pavese deve il suo successo presso il grande pubblico.
 Da Moneta e civiltà mediterranea (1957) Le avventure della lira (1975), da La storia economica (1998) a Il governo della moneta a Firenze e a Milano nei secoli XIV-XVI (1990) passando per saggi dedicati a “vele e cannoni”, alla storia dell’orologio, agli effetti delle pestilenze e a quelli dell’alfabetizzazione, ovunque nell’opera di Cipolla – che tutti i cultori di numismatica dovrebbero leggere – la moneta fa capolino come una sorta di “genio universale”.
Da Moneta e civiltà mediterranea (1957) Le avventure della lira (1975), da La storia economica (1998) a Il governo della moneta a Firenze e a Milano nei secoli XIV-XVI (1990) passando per saggi dedicati a “vele e cannoni”, alla storia dell’orologio, agli effetti delle pestilenze e a quelli dell’alfabetizzazione, ovunque nell’opera di Cipolla – che tutti i cultori di numismatica dovrebbero leggere – la moneta fa capolino come una sorta di “genio universale”.
E geniale è stato anche Carlo M. Cipolla, del quale in tanti si sono chiesti per cosa stesse quella “M”. “Non sta per niente”, come è stato svelato qualche anno fa: venne infatti scelta dal nostro nel suo periodo americano solo per non essere confuso con un suo omonimo. Per l’esattezza fu quando nella seconda metà degli anni Quaranta, a seguito della pubblicazione di uno dei suoi primi saggi, la casa editrice inviò per errore delle copie a un Carlo Cipolla residente in Sicilia. Fu allora che il nostro decise di aggiungere quella seconda iniziale al suo nome.
L’ironia e l’arguzia erano del resto tra le qualità più spiccate del professore (approfondisci qui), tanto che ci piace concludere questo ricordo non tanto con un suo aneddoto riguardante le monete quanto con il celeberrimo, intramontabile diagramma dei profili comportamentali umani – un esempio di sintesi eccezionale – tratto dal saggio The Basics Laws of Human Stupidity pubblicato per la prima volta nel 1976… come regalo di Natale agli amici!